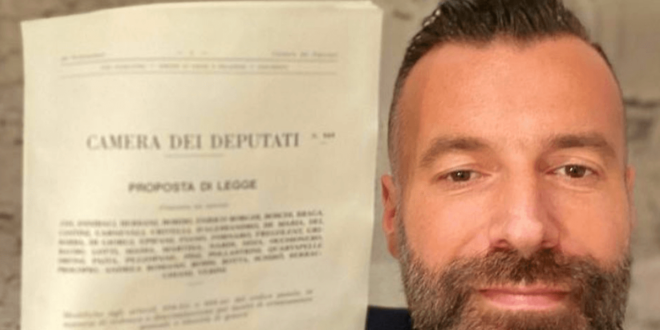Si fa un gran parlare in questi giorni del DDL Zan, che nelle intenzioni del relatore dovrebbe fornire una tutela supplementare ad alcuni gruppi sociali, maggiormente colpiti dall’intolleranza.
di Andrea Zhok
Le minoranze etniche sono già tutelate dalla legge Mancino del 1993, e il presente DDL dovrebbe estendere questa tutela speciale a soggetti discriminati in base a “sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, o disabilità.”
Le polemiche sul tema sono roventi, e rese anche più complesse dalla difficoltà di comprendere cosa concretamente implichi il testo di legge, visto che interviene in forma emendativa dell’articolo 604-bis del codice penale.

Ci saranno sicuramente le motivazioni più variegate tra coloro i quali sono ostili o diffidenti nei confronti del DDL, ma una linea critica mi pare abbastanza chiara: l’idea che certi gruppi sociali in quanto tali, a prescindere dalle condizioni reali in cui si trovino i soggetti coinvolti, debbano ottenere una tutela speciale suona come un privilegio.
E ogni volta che si definisce un gruppo come portatore di un privilegio (ogni volta che è percepito come tale), si crea una frattura ulteriore nella società (non necessariamente benefica per il privilegiato stesso).

Il problema oggettivo, tuttavia, è che la coincidenza tra i gruppi sociali citati ed una condizione di inferiorità o debolezza comparativa è abbastanza vaga e problematica. Si presenta talvolta, ma – salvo forse nel caso dei disabili – è ben lungi dal rappresentare una regola generale.
Ecco, a titolo di contributo su un tema così spinoso, io credo che sia utile introdurre una distinzione concettuale, distinzione che la normativa vigente NON prende in considerazione, creando confusioni e casi problematici, che verrebbero semplicemente amplificati dagli emendamenti proposti. Esiste la tendenza a mescolare negli articoli di legge – quelli prospettati e quelli in vigore – due istanze differenti, che dovrebbero essere valutate separatamente.

Tuttavia le condizioni di inferiorità sono numerosissime, e non possono mai essere elencate in modo esaustivo. Può essere un disabile, un anziano, un malato uscito dalla chemioterapia, un bambino, una donna fragile, e un’infinità di altri casi, che possono essere valutati soltanto da un giudice, valutando il contesto dell’aggressione.
La seconda istanza è l’esigenza di colpire ideologie o visioni che riteniamo inaccettabili (ad esempio perché incostituzionali). Così aggressioni fisiche o morali accompagnate da giudizi di tipo discriminante con riferimento a “sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali” (Art. 3 della Costituzione) devono comportare accanto al reato di aggressione un reato supplementare di discriminazione.

Lo stesso può avvenire nel caso in cui non c’è alcuna aggressione, ma semplice propaganda rivolta a discriminare per sesso, razza, religione, ecc. Dunque:
- Se X aggredisce Y, che è un soggetto in condizioni di inferiorità (disabile, fragile, ecc.) scatta un’aggravante al reato di aggressione.
- Se X, mentre aggredisce Y inveisce contro un gruppo sociale con intento discriminatorio (inveisce contro qualcuno in quanto di colore, cinese, musulmano, omosessuale, ecc.), le espressioni di accompagnamento rappresentano un secondo reato, da valutare separatamente e addizionalmente.

Separando le due fattispecie in due reati distinti si toglie di mezzo il problema del privilegio immotivato, della ‘protezione speciale’ senza ragioni. Si evitano cioè casi esemplificabili in termini di questo genere: due automobilisti si prendono a botte per un parcheggio, e in seconda battuta uno dei due, appartenente ad una ‘categoria protetta’ asserisce di essere stato aggredito in quanto membro di detta categoria.

Invece tenendo separate le due fattispecie di reato, per cui si richiedono pezze d’appoggio specifiche, e non facendole collassare in termini di ‘aggravanti’ di un medesimo reato, si ottiene egualmente sia la desiderata protezione sociale dei più deboli, sia lo scoraggiamento di atti discriminatori.
Si evita però la condizione di ambiguità per cui l’identità ‘percepita’ o ‘auto-dichiarata’ di uno dei soggetti possa diventare di per sé una clausola legale preferenziale, una tutela speciale.
 Elzeviro Informazione indipendente
Elzeviro Informazione indipendente