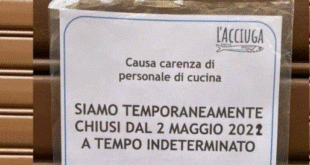CARO PRODI, IL SUICIDIO È STATO ENTRARE NELL’EURO
di Thomas Fazi
L’ineffabile Romano Prodi ha dichiarato a DiMartedì che
il ritorno alla lira sarebbe assolutamente un suicidio.
Ora, che Prodi senta il bisogno di fare la difesa d’ufficio dell’euro è comprensibile:
d’altronde fu proprio il suo governo, nel 1996, ad avviare le procedure per l’ingresso dell’Italia nell’euro. Ma proprio per questo dovrebbe avere la decenza di non parlare.
Cosa accadrebbe in caso di uscita dall’euro, infatti, non lo sappiamo: molto dipenderebbe da come verrebbe gestita la cosa, e alcuni degli economisti più brillanti del pianeta ci hanno indicato la strada su come gestire e minimizzare l’impatto di una transizione dall’euro a una nuova valuta nazionale.
Quello che invece sappiamo per certo sono gli effetti che ha avuto l’ingresso dell’Italia nell’euro.
Fino alla fine degli anni Ottanta, l’Italia è stato il paese d’Europa con la più elevata crescita media. Poi, tra l’inizio e la metà degli anni Novanta, quel trend non ha solo subìto una brusca frenata, ma ha addirittura conosciuto una drammatica inversione di tendenza.
Inversione di tendenza che dura fino ai giorni nostri,
relativamente in particolare alla produzione industriale, alla produttività e al PIL pro capite: tutte variabili che fino a quel momento avevano registrato un tasso di crescita superiore o pari a quello della Germania e degli altri partner europei.

Il fatto che la dinamica del PIL italiano non denoti una marcata tendenza al declino, almeno rispetto alla Germania e alla media europea, prima dell’introduzione dell’euro, dovrebbe essere sufficiente a smentire la teoria secondo cui la crisi sarebbe imputabile a problemi strutturali che poco o nulla hanno a che vedere con l’integrazione economica e valutaria europea.
Il dato relativo all’andamento della produttività è particolarmente interessante,
sia perché la bassa produttività dell’Italia è spesso additata come l’origine di tutti i mali del nostro paese, sia perché essa rappresenta la cartina di tornasole di tutta una serie di altre criticità.
Per tutti gli anni Settanta e Ottanta
la produttività italiana del lavoro ha viaggiato allo stesso ritmo di quella tedesca; all’inizio degli anni Novanta, poi, l’indice della produttività comincia a rallentare per poi arrestarsi bruscamente nel 1997.
Da allora è sempre cresciuta a tassi molto inferiori alla media delle economie avanzate, mentre quella tedesca, pur continuando a rallentare, è rimasta vicina alla media.
Cosa è successo tra l’inizio e la metà degli anni Novanta?
Sono emerse improvvise “debolezze strutturali” nella nostra economia? Siamo diventati d’un colpo tutti corrotti e scansafatiche? O in quegli anni sono state prese delle precise decisioni politiche che potrebbero spiegare la curiosa parabola dell’economia italiana?
Sarà una coincidenza
– o quella che gli economisti chiamano una “correlazione spuria” – ma quelli sono gli anni in cui inizia il percorso di convergenza del nostro paese verso i criteri di Maastricht, che ha implicato non solo il fissaggio del tasso di cambio e una stretta fiscale estremamente violenta, ma anche un programma di (contro)riforme – tra cui
- la liberalizzazione di molti settori,
- lo smantellamento e privatizzazione di buona parte dell’apparato industriale pubblico,
- la deregolamentazione del mercato del lavoro ecc. –
che ha investito praticamente ogni aspetto dell’economia italiana.
Una prima causa del crollo della produttività
va dunque individuata nella rivalutazione della lira propedeutica all’ingresso dell’Italia nell’euro: nel 1995, dopo aver raggiunto la massima svalutazione rispetto al marco, la lira si rivaluta bruscamente, per poi continuare ad apprezzarsi nei mesi seguenti, fino a raggiungere l’anno successivo quello che sarebbe diventato il cambio irrevocabile fra la lira e il marco.
L’impatto sulle esportazioni non tardò a farsi sentire.
La svalutazione della lira rispetto al marco iniziata nel 1992 aveva dato un forte impulso all’export italiano, tanto che nel 1993 la bilancia commerciale era tornata in attivo (dopo essere stata in territorio negativo per diversi anni), continuando a crescere a ritmi poderosi negli anni successivi.
Poi, a partire dal 1997 –
cioè da quando viene nuovamente fissato il tasso di cambio, provocando un’immediata rivalutazione della lira – la nostra bilancia commerciale comincia nuovamente a declinare, per entrare nuovamente in territorio negativo nel 2002, cioè nell’anno in cui l’euro entra ufficialmente in circolazione.
I numeri parlano chiaro:
negli anni Novanta le esportazioni italiane erano molto sensibili (elastiche, nel gergo degli economisti) rispetto alle variazioni di prezzo, da cui l’impatto molto pesante sulla manifattura determinato dall’adozione del cambio fisso e poi della moneta unica.
Come scrive Antonella Stirati in merito al peggioramento della bilancia commerciale italiana verificatosi nel corso dell’ultimo ventennio,
la perdita di controllo sul tasso di cambio, insieme alla scarsa crescita del mercato interno tedesco, hanno pesato negativamente molto più che l’emergere di nuovi paesi nella scena economica internazionale.
(come per esempio la Cina).

Un’altra causa del crollo della produttività può essere individuata nella progressiva deregolamentazione e flessibilizzazione (precarizzazione) del mercato del lavoro cui abbiamo assistito nell’ultimo ventennio, dal pacchetto Treu (1997) fino al “Jobs Act” e all’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (2014).
Il risultato di questo processo – anch’esso parte integrante del percorso di convergenza inaugurato con la firma del trattato di Maastricht, in linea con l’impostazione antilaburista dell’unione monetaria – è che per l’Italia l’indice di protezione del lavoro (EPL), calcolato dall’OCSE, è precipitato da 3,8 nei prima anni Novanta a poco più di 2 nel 2015 (ultimo anno per il quale disponiamo di dati).
Come ammette la stessa OCSE, siamo il paese che ha liberalizzato di più il mercato del lavoro
relativamente alla posizione abbastanza rigida del passato. A sentire la Commissione europea e la BCE, che non perdono mai occasione di invocare le cosiddette “riforme strutturali”, in particolare la deregolamentazione del mercato del lavoro, ridurre i diritti dei lavoratori sarebbe una necessità impellente al fine di accrescere la produttività stagnante delle imprese.
Eppure, se si giudicano i risultati della flessibilità, vediamo che essa non è stata accompagnata da un aumento della produttività ma, al contrario, da un drammatico crollo della suddetta.
Come se non bastasse, la produttività italiana ha risentito anche delle politiche di compressione della domanda e di restrizione fiscale adottate sempre con l’obiettivo dichiarato di ottemperare ai criteri di Maastricht.
A partire dalla metà degli anni Novanta, infatti, la spesa pubblica corrente si è sistematicamente ridotta, con una contrazione di circa un punto percentuale solo tra il 1993 e il 1994. Da allora la spesa pubblica italiana in rapporto al PIL è sempre stata – e continua a essere – sistematicamente inferiore a quella degli altri paesi avanzati.
Nello stesso periodo l’Italia è anche il paese, fra quelli OCSE, che ha registrato la maggiore crescita delle diseguaglianze e il maggior grado di immobilità sociale.
Il risultato è che da un ventennio l’Italia ha visto crescere la sua domanda interna a tassi sistematicamente più bassi della media dei paesi OCSE. Questo, nota Guglielmo Forges Davanzati,
sembra confermare l’ipotesi interpretativa in base alla quale la riduzione della spesa pubblica contribuisce a generare effetti di segno negativo sulla dinamica della produttività del lavoro.
In definitiva, nella misura in cui tra l’inizio e la metà degli anni Novanta, tutti i maggiori indicatori economici – produttività, produzione industriale, crescita pro capite ecc. –
hanno cominciato a manifestare un costante declino e risultano sostanzialmente stagnanti da allora, con tutte le conseguenze economiche e sociali che ne sono derivate.
Questo è largamente imputabile alla radicale riconfigurazione del nostro assetto economico-istituzionale conseguente all’adesione dell’Italia alla sovrastruttura economica europea e alle varie (contro)riforme regressive ad essa associate:
- fissaggio del tasso di cambio (con conseguente crollo delle esportazioni),
- deregolamentazione del mercato del lavoro,
- compressione dei salari,
- politiche fiscali restrittive e
- privatizzazione della grande industria pubblica.
È la stessa conclusione raggiunta dal noto economista olandese Servaas Storm nello studio più approfondito che sia mai stato realizzato sulle cause del lungo declino italiano:
Nello studio – scrive Storm –
dimostro empiricamente come la recessione italiana debba considerarsi una conseguenza del nuovo regime economico post-Maastricht adottato dall’Italia a partire dai primi anni Novanta.
Per concludere: l’uscita dall’euro è un’incognita, ma non vi sono ragioni per credere che sarebbe necessariamente «un suicidio», come dice Prodi; anzi, vi sono ottime ragioni per credere che
sarebbe la condizione essenziale per tornare a vivere.
Al contrario, sappiamo per certo che l’ingresso dell’Italia nell’euro è stato – quello sì – un suicidio. Anche se forse sarebbe meglio parlare di tentato omicidio.
 Elzeviro Informazione indipendente
Elzeviro Informazione indipendente